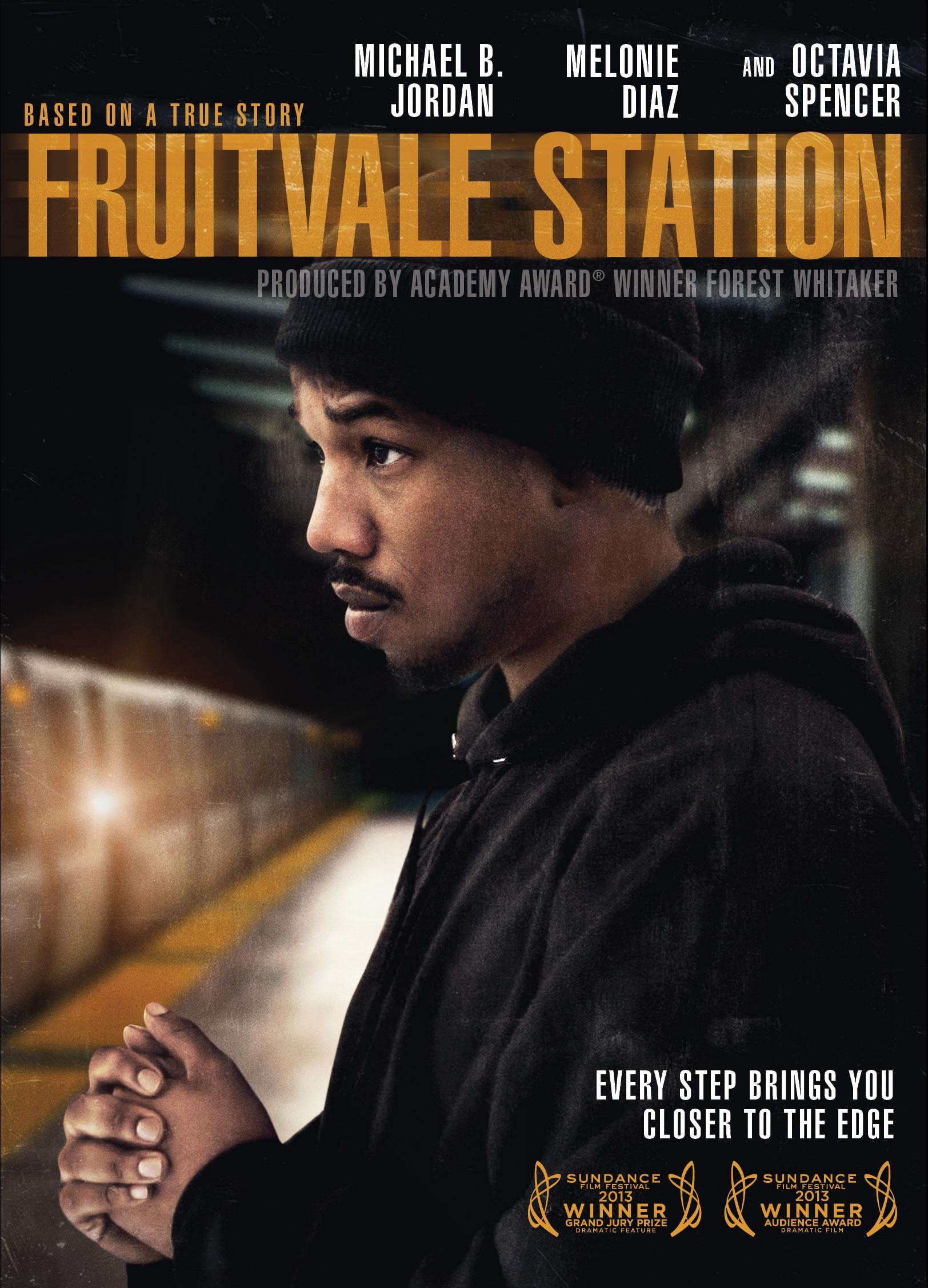La luna su Torino
di Davide Ferrario
con Walter Leonardi, Manuela Parodi, Eugenio Franceschini
Italia, 2013
genere. commedia
durata. 90'
 A dispetto di un curriculum che lo ha visto non solo regista ma anche
talent scout, con rassegne che hanno fatto conoscere in Italia le prime
opere di un regista del calibro di Krzysztof Kieślowski, Davide Ferrario
nel corso della carriera ha mostrato un approccio diretto e mai mediato
rispetto alla materia dei suoi film, sperimentando generi e formati
sempre concentrati sul fattore umano e sull'ambiente che lo influenza.
Ed è proprio questo determinismo energetico e geografico ad ispirare il
suo nuovo lavoro intitolato "La luna su Torino". Già il titolo è
indicativo del connubio che sta alla base del film: la capitale sabauda,
ancora una volta protagonista dopo le incursioni di "Tutti giù per
terra" e "Dopo Mezzanotte", e poi la Luna, influenza celeste che sintonizza il mood
del racconto, conferendogli quel misto di romanticismo e levità di cui
sono intrise le esperienze dei tre protagonisti, due ragazzi e una
ragazza che si dividono una villa immersa nello splendido scenario della
collina torinese. Giulio quarantenne perdigiorno passa le sue giornate
tra una lettura di Leopardi ed escursioni in bicicletta per le vie della
città, Maria aspirante attrice è impiegata in un'agenzia di viaggi che
assomiglia a un club per cuori solitari e, infine, Mario, studente di
lettere che lavora in un bioparco dove animali e persone convivono in
piena armonia. Tutti e tre sono alla ricerca di qualcosa che gratifichi
le loro aspirazioni, l'amore probabilmente, il senso della vita
sicuramente.
A dispetto di un curriculum che lo ha visto non solo regista ma anche
talent scout, con rassegne che hanno fatto conoscere in Italia le prime
opere di un regista del calibro di Krzysztof Kieślowski, Davide Ferrario
nel corso della carriera ha mostrato un approccio diretto e mai mediato
rispetto alla materia dei suoi film, sperimentando generi e formati
sempre concentrati sul fattore umano e sull'ambiente che lo influenza.
Ed è proprio questo determinismo energetico e geografico ad ispirare il
suo nuovo lavoro intitolato "La luna su Torino". Già il titolo è
indicativo del connubio che sta alla base del film: la capitale sabauda,
ancora una volta protagonista dopo le incursioni di "Tutti giù per
terra" e "Dopo Mezzanotte", e poi la Luna, influenza celeste che sintonizza il mood
del racconto, conferendogli quel misto di romanticismo e levità di cui
sono intrise le esperienze dei tre protagonisti, due ragazzi e una
ragazza che si dividono una villa immersa nello splendido scenario della
collina torinese. Giulio quarantenne perdigiorno passa le sue giornate
tra una lettura di Leopardi ed escursioni in bicicletta per le vie della
città, Maria aspirante attrice è impiegata in un'agenzia di viaggi che
assomiglia a un club per cuori solitari e, infine, Mario, studente di
lettere che lavora in un bioparco dove animali e persone convivono in
piena armonia. Tutti e tre sono alla ricerca di qualcosa che gratifichi
le loro aspirazioni, l'amore probabilmente, il senso della vita
sicuramente.
 Mettendo a frutto esperienza artistica - il
documentario innanzitutto - e motivi personali, Davide Ferrario riscrive
a suo modo la mappa urbanistica della città operando in una direzione
di vera e propria rivalutazione degli spazi abitativi. In questo modo i
luoghi della mondanità classicamente intesi, pur presenti, rimangono
laterali per fare largo a strutture di una Torino alternativa e
post-olimpica che, nel mix di prospettive sfuggenti e di geometrie
avveniristiche, si trasforma in puzzle surreale e cubista, in cui le
divagazioni dei tre personaggi diventano il mezzo per raccontare lo
spirito di una città proiettata verso il futuro - la metafora del 45°
parallelo in cui Torino si colloca e che la collega al resto
dell'ecumene - ma saldamente ancorata alla sua identità, presente nei
ricordi e nelle abitudini dei vecchietti che Giulio va a trovare durante
i suoi raid quotidiani.
Mettendo a frutto esperienza artistica - il
documentario innanzitutto - e motivi personali, Davide Ferrario riscrive
a suo modo la mappa urbanistica della città operando in una direzione
di vera e propria rivalutazione degli spazi abitativi. In questo modo i
luoghi della mondanità classicamente intesi, pur presenti, rimangono
laterali per fare largo a strutture di una Torino alternativa e
post-olimpica che, nel mix di prospettive sfuggenti e di geometrie
avveniristiche, si trasforma in puzzle surreale e cubista, in cui le
divagazioni dei tre personaggi diventano il mezzo per raccontare lo
spirito di una città proiettata verso il futuro - la metafora del 45°
parallelo in cui Torino si colloca e che la collega al resto
dell'ecumene - ma saldamente ancorata alla sua identità, presente nei
ricordi e nelle abitudini dei vecchietti che Giulio va a trovare durante
i suoi raid quotidiani.
In tale sipario la realtà si frantuma in un'esplosione di fantasie pirotecniche in cui entrano in gioco suggestioni letterarie - non solo quelle derivate dalle parole del sommo poeta mai come oggi così in voga, ma anche di Giulio intento a scrivere il romanzo di una gioventù percepita nella sua indeterminatezza - e passione cinefila, inserita attraverso il personaggio di Maria, appassionata di cinema muto, consumato con un'immedesimazione che prende forma nei trasfert ad occhi aperti in cui la ragazza si sostituisce alle dive dello schermo per sublimare i tormenti della sua irrequietezza.
Alle prese con un soggetto di sublime inconsistenza per l'esilità di una trama che procede per assonanze sentimentali e slanci emotivi, "La luna di Torino" dà vita a una piacevole anomalia, diventando poesia con una profondità che si nutre di divertimento (basterebbe il filone dedicato al rapporto tragicomico tra Giulio e le donne) e di una libertà di cui è manifesto la sequenza d'apertura, quella che trasforma la ricognizione notturna effettuata in assenza di gravità in una danza di traiettorie che sembrano definire l'essenza stessa del film. Insieme a questo il merito di aver proposto la novità dei volti di Walter Leonardi, Manuela Parodi ed Eugenio Franceschini, perfetti nel convertire la freschezza delle prime volte nella contagiosa ingenuità dei personaggi.
Passato al festival fuori concorso, il film è stato molto applaudito al termine della proiezione. Un buon auspicio per l'uscita nelle sale, annunciata per il marzo del prossimo anno.
(pubblicato su ondacinema.it)
di Davide Ferrario
con Walter Leonardi, Manuela Parodi, Eugenio Franceschini
Italia, 2013
genere. commedia
durata. 90'
 A dispetto di un curriculum che lo ha visto non solo regista ma anche
talent scout, con rassegne che hanno fatto conoscere in Italia le prime
opere di un regista del calibro di Krzysztof Kieślowski, Davide Ferrario
nel corso della carriera ha mostrato un approccio diretto e mai mediato
rispetto alla materia dei suoi film, sperimentando generi e formati
sempre concentrati sul fattore umano e sull'ambiente che lo influenza.
Ed è proprio questo determinismo energetico e geografico ad ispirare il
suo nuovo lavoro intitolato "La luna su Torino". Già il titolo è
indicativo del connubio che sta alla base del film: la capitale sabauda,
ancora una volta protagonista dopo le incursioni di "Tutti giù per
terra" e "Dopo Mezzanotte", e poi la Luna, influenza celeste che sintonizza il mood
del racconto, conferendogli quel misto di romanticismo e levità di cui
sono intrise le esperienze dei tre protagonisti, due ragazzi e una
ragazza che si dividono una villa immersa nello splendido scenario della
collina torinese. Giulio quarantenne perdigiorno passa le sue giornate
tra una lettura di Leopardi ed escursioni in bicicletta per le vie della
città, Maria aspirante attrice è impiegata in un'agenzia di viaggi che
assomiglia a un club per cuori solitari e, infine, Mario, studente di
lettere che lavora in un bioparco dove animali e persone convivono in
piena armonia. Tutti e tre sono alla ricerca di qualcosa che gratifichi
le loro aspirazioni, l'amore probabilmente, il senso della vita
sicuramente.
A dispetto di un curriculum che lo ha visto non solo regista ma anche
talent scout, con rassegne che hanno fatto conoscere in Italia le prime
opere di un regista del calibro di Krzysztof Kieślowski, Davide Ferrario
nel corso della carriera ha mostrato un approccio diretto e mai mediato
rispetto alla materia dei suoi film, sperimentando generi e formati
sempre concentrati sul fattore umano e sull'ambiente che lo influenza.
Ed è proprio questo determinismo energetico e geografico ad ispirare il
suo nuovo lavoro intitolato "La luna su Torino". Già il titolo è
indicativo del connubio che sta alla base del film: la capitale sabauda,
ancora una volta protagonista dopo le incursioni di "Tutti giù per
terra" e "Dopo Mezzanotte", e poi la Luna, influenza celeste che sintonizza il mood
del racconto, conferendogli quel misto di romanticismo e levità di cui
sono intrise le esperienze dei tre protagonisti, due ragazzi e una
ragazza che si dividono una villa immersa nello splendido scenario della
collina torinese. Giulio quarantenne perdigiorno passa le sue giornate
tra una lettura di Leopardi ed escursioni in bicicletta per le vie della
città, Maria aspirante attrice è impiegata in un'agenzia di viaggi che
assomiglia a un club per cuori solitari e, infine, Mario, studente di
lettere che lavora in un bioparco dove animali e persone convivono in
piena armonia. Tutti e tre sono alla ricerca di qualcosa che gratifichi
le loro aspirazioni, l'amore probabilmente, il senso della vita
sicuramente. Mettendo a frutto esperienza artistica - il
documentario innanzitutto - e motivi personali, Davide Ferrario riscrive
a suo modo la mappa urbanistica della città operando in una direzione
di vera e propria rivalutazione degli spazi abitativi. In questo modo i
luoghi della mondanità classicamente intesi, pur presenti, rimangono
laterali per fare largo a strutture di una Torino alternativa e
post-olimpica che, nel mix di prospettive sfuggenti e di geometrie
avveniristiche, si trasforma in puzzle surreale e cubista, in cui le
divagazioni dei tre personaggi diventano il mezzo per raccontare lo
spirito di una città proiettata verso il futuro - la metafora del 45°
parallelo in cui Torino si colloca e che la collega al resto
dell'ecumene - ma saldamente ancorata alla sua identità, presente nei
ricordi e nelle abitudini dei vecchietti che Giulio va a trovare durante
i suoi raid quotidiani.
Mettendo a frutto esperienza artistica - il
documentario innanzitutto - e motivi personali, Davide Ferrario riscrive
a suo modo la mappa urbanistica della città operando in una direzione
di vera e propria rivalutazione degli spazi abitativi. In questo modo i
luoghi della mondanità classicamente intesi, pur presenti, rimangono
laterali per fare largo a strutture di una Torino alternativa e
post-olimpica che, nel mix di prospettive sfuggenti e di geometrie
avveniristiche, si trasforma in puzzle surreale e cubista, in cui le
divagazioni dei tre personaggi diventano il mezzo per raccontare lo
spirito di una città proiettata verso il futuro - la metafora del 45°
parallelo in cui Torino si colloca e che la collega al resto
dell'ecumene - ma saldamente ancorata alla sua identità, presente nei
ricordi e nelle abitudini dei vecchietti che Giulio va a trovare durante
i suoi raid quotidiani.In tale sipario la realtà si frantuma in un'esplosione di fantasie pirotecniche in cui entrano in gioco suggestioni letterarie - non solo quelle derivate dalle parole del sommo poeta mai come oggi così in voga, ma anche di Giulio intento a scrivere il romanzo di una gioventù percepita nella sua indeterminatezza - e passione cinefila, inserita attraverso il personaggio di Maria, appassionata di cinema muto, consumato con un'immedesimazione che prende forma nei trasfert ad occhi aperti in cui la ragazza si sostituisce alle dive dello schermo per sublimare i tormenti della sua irrequietezza.
Alle prese con un soggetto di sublime inconsistenza per l'esilità di una trama che procede per assonanze sentimentali e slanci emotivi, "La luna di Torino" dà vita a una piacevole anomalia, diventando poesia con una profondità che si nutre di divertimento (basterebbe il filone dedicato al rapporto tragicomico tra Giulio e le donne) e di una libertà di cui è manifesto la sequenza d'apertura, quella che trasforma la ricognizione notturna effettuata in assenza di gravità in una danza di traiettorie che sembrano definire l'essenza stessa del film. Insieme a questo il merito di aver proposto la novità dei volti di Walter Leonardi, Manuela Parodi ed Eugenio Franceschini, perfetti nel convertire la freschezza delle prime volte nella contagiosa ingenuità dei personaggi.
Passato al festival fuori concorso, il film è stato molto applaudito al termine della proiezione. Un buon auspicio per l'uscita nelle sale, annunciata per il marzo del prossimo anno.
(pubblicato su ondacinema.it)