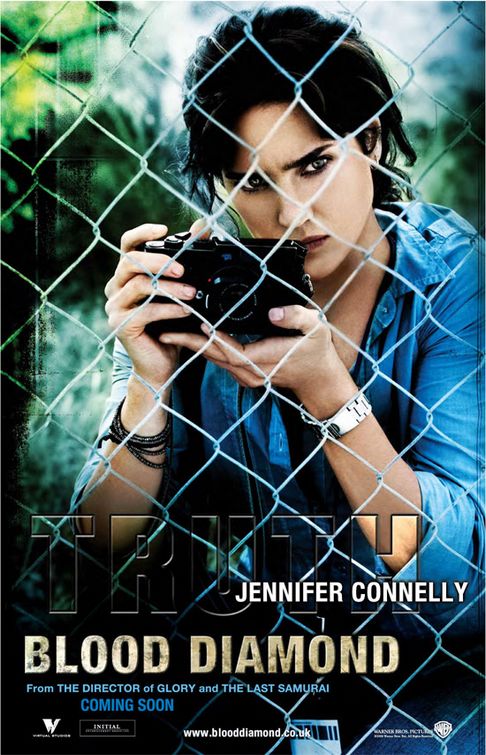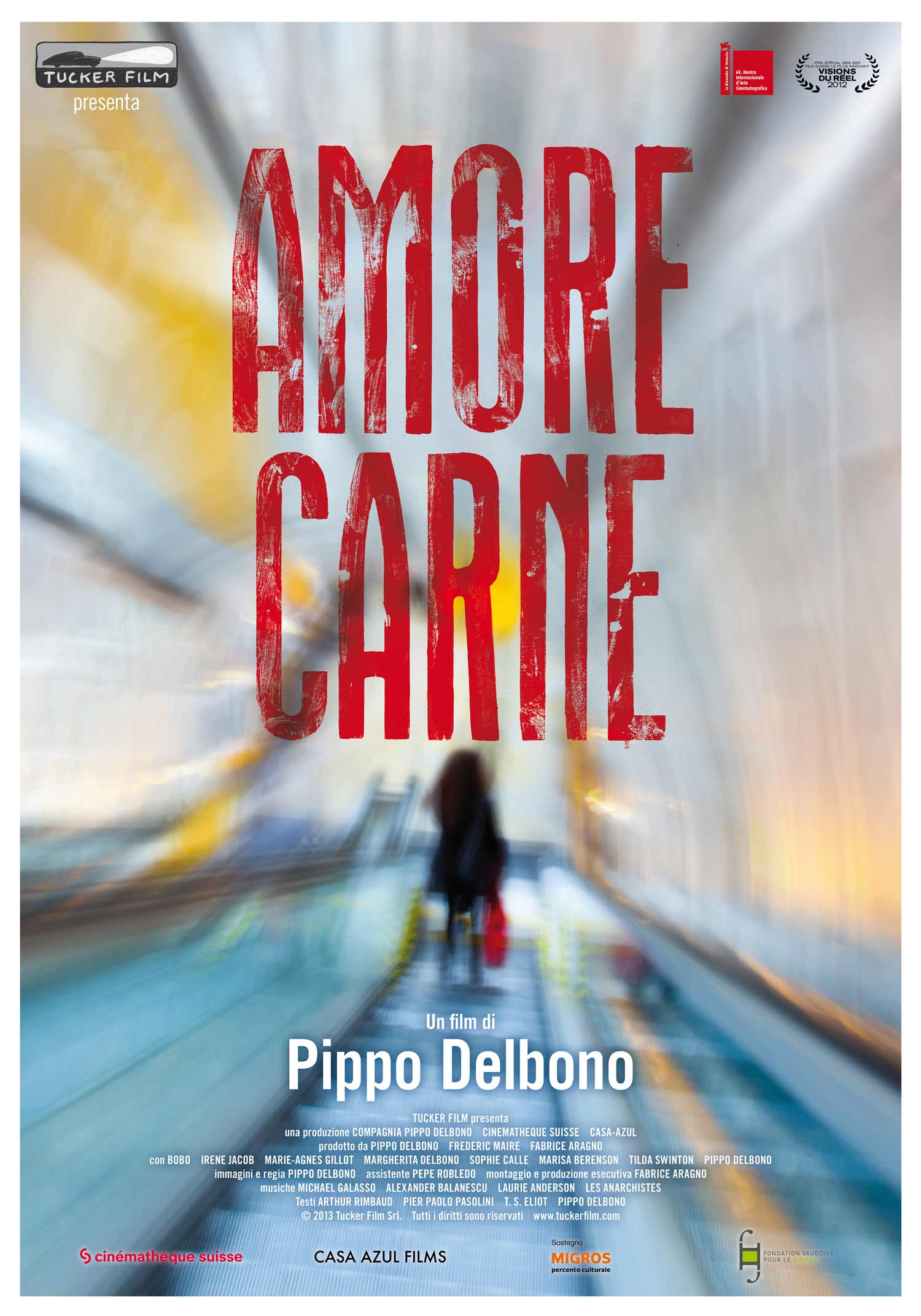The Lone Ranger
di Gore Verbinski
con J.Deep, Armie Hammer, H.B. Carter
Usa 2013
genere, western, avventura, azione
durata, 149'
Il genere western è un monolite a se stante, praticamente irriducibile a qualsiasi tentativo di riformularne la proposta. La storia lo dimostra persino quando, nel tentativo di rilanciarlo sono accorsi al suo capezzale attori e produttori di grido costretti, salvo rare eccezioni – “Balla con i lupi”1990 e “Gli spietati”1992 - a constatarne un carattere senza compromessi e legato indissolubilmente ad una stagione irripetibile del cinema americano. Se poi si tratta di trovare una spiegazione a questo “The Lone Ranger”, ultimo di una serie di prodotti escogitati per ravvivare la vulgata con toni da commedia ed esperienze metafisiche, allora il discorso si fa ancora più scoraggiante, con precendenti di potenziali campioni come "Wild Wild West", (1999) e "Monsters and Aliens" (2011) che tali non sono mai diventati. Ed allora ci si potrebbe chiedere per quale motivo il trio Bruckheimer/Verbinski/Deep tanto oculato nelle scelta dei progetti su cui investire tempo e soprattutto denaro sia stato capace di impatanarsi in un'operazione così rischiosa, tentando di coniugare John Wayne e Gary Cooper a Stan Lauren ed Harold Loyd. Eccesso d’onnipotenza forse, visto lo strepitoso successo della saga de "I Pirati dei Caraibi"di cui i tre sono stati i principali artefici, o forse il fatto di poter contare su un classico del genere come quello delle avventure dell’improbabile sceriffo, John Reid, e del suo aiutante Tonto, un indiano alla mister Magoo, impersonato manco a farlo a posta da un Johnny Deep, lui si ormai perso in una battaglia personale alla rincorsa del travestimento più bello del reame.
di Gore Verbinski
con J.Deep, Armie Hammer, H.B. Carter
Usa 2013
genere, western, avventura, azione
durata, 149'
Il genere western è un monolite a se stante, praticamente irriducibile a qualsiasi tentativo di riformularne la proposta. La storia lo dimostra persino quando, nel tentativo di rilanciarlo sono accorsi al suo capezzale attori e produttori di grido costretti, salvo rare eccezioni – “Balla con i lupi”1990 e “Gli spietati”1992 - a constatarne un carattere senza compromessi e legato indissolubilmente ad una stagione irripetibile del cinema americano. Se poi si tratta di trovare una spiegazione a questo “The Lone Ranger”, ultimo di una serie di prodotti escogitati per ravvivare la vulgata con toni da commedia ed esperienze metafisiche, allora il discorso si fa ancora più scoraggiante, con precendenti di potenziali campioni come "Wild Wild West", (1999) e "Monsters and Aliens" (2011) che tali non sono mai diventati. Ed allora ci si potrebbe chiedere per quale motivo il trio Bruckheimer/Verbinski/Deep tanto oculato nelle scelta dei progetti su cui investire tempo e soprattutto denaro sia stato capace di impatanarsi in un'operazione così rischiosa, tentando di coniugare John Wayne e Gary Cooper a Stan Lauren ed Harold Loyd. Eccesso d’onnipotenza forse, visto lo strepitoso successo della saga de "I Pirati dei Caraibi"di cui i tre sono stati i principali artefici, o forse il fatto di poter contare su un classico del genere come quello delle avventure dell’improbabile sceriffo, John Reid, e del suo aiutante Tonto, un indiano alla mister Magoo, impersonato manco a farlo a posta da un Johnny Deep, lui si ormai perso in una battaglia personale alla rincorsa del travestimento più bello del reame.
Un riferimento quello di Jack Sparrow e della sua banda non del tutto campato in aria se è vero che “The Lone Ranger” sembra in qualche modo la messainscena dello stesso format, con canyon e praterie al posto del mare e delle isole, e personaggi, ancora una volta “in costume”, impegnati a sfidare il male con una comicità picaresca e slapstick all'interno di uno spirito avventuroso da luna park delle meraviglie. In questo caso c’è di mezzo una banda di assassini capitanati da Butch Cavendish, ed il proposito di consegnarlo alla giustizia da parte del cavaliere solitario, diventato tale in sostituzione del fratello, ucciso dallo spietato manigoldo.
Diviso in due sezioni, con la prima, introduttiva, che da modo ai personaggi di presentarsi e di stabilire le dinamiche delle azioni successive, e la seconda a far la parte del leone, con scontri interminabili e sfide mirabolanti, “The Lone Ranger”punta molto sulla magnificenza del paesaggio, nell'intento di far scaturire il mistero e l'imponderabilità del fato dalla sublime potenza della sua natura desolata e selvaggia. Ma il talento morfologico del territorio, le doti funamboliche della macchina da presa, ed uno spartito di battute non proprio memorabili non riescono a compensare la ripetizione di un canovaccio di interminabile durata, con treni in corsa e duelli rusticani duplicati a più non posso. Delusione che riguarda anche gli attori: da Armie Hammer (The Lone Ranger), privo della necessaria personalità a Johnny Deep (Tonto), a cui viene a mancare l'effetto sorpresa, quello che aveva preso in contropiede i cultori del suo cinema predisponendoli ad una sobria accettazione di una trasformazione attoriale diventata pantomima, per non parlare della presenza bozzettistica di Helen Boham Carter, sempre più a suo agio nel ruolo di regina dei freak. Il botteghino per una volta aiuta, decretando un flop così altisonante da mettere in archivio eventuali seguiti.