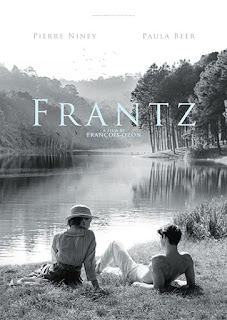Solaris
di Andrej Tarkovskij
con Donatas Banionis, Natal'ja Bondarčuk, Jüri Järvet, Anatolij Solonicyn, Nikolai Grinko, Olga Barnet
Urss, 1972
genere, fantascienza
durata, 167’
 Nel trentennale della scomparsa di Andrej Tarkovskij, la Fondazione Cineteca Italiana dedica una personale al regista con la proiezione della filmografia completa originale e integrale. Fino al 4 ottobre potrete avere la possibilità di scoprire (per chi non lo conoscesse) o di rivedere le opere di uno degli autori più importati della seconda metà del Novecento della Settima arte. Di seguito la recensione di Solaris, tra i suoi film più famosi e acclamatii.
Nel trentennale della scomparsa di Andrej Tarkovskij, la Fondazione Cineteca Italiana dedica una personale al regista con la proiezione della filmografia completa originale e integrale. Fino al 4 ottobre potrete avere la possibilità di scoprire (per chi non lo conoscesse) o di rivedere le opere di uno degli autori più importati della seconda metà del Novecento della Settima arte. Di seguito la recensione di Solaris, tra i suoi film più famosi e acclamatii.
In un futuro dove l’uomo viaggia nello Spazio, da molti anni una base spaziale orbita intorno al pianeta alieno Solaris, mondo-senziente, completamente liquido, pianeta/cervello, con cui l’umanità cerca un contatto, creando una vera e propria branca scientifica: la “solaristica”. Ma tutti i tentativi di comunicazione falliscono per l’incapacità di creare un dialogo sotto qualsiasi forma. Ormai quasi abbandonata (ci sono solo più tre scienziati rimasti che continuano a compiere esperimenti), viene inviato lo psicologo Kris Kelvin per decidere la chiusura della base spaziale.
Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore polacco Stanislaw Lem, Solaris è un esempio di fantascienza filosofica in cui si affronta la difficoltà dell’umanità (e la sua inadeguatezza) a comunicare con altre forme di vita aliene. L’Altro diventa personaggio per spiegare la Cosa irrappresentabile e Tarkovskij riprende e mantiene questo aspetto originale della fonte letteraria, introducendo la sua visione d’artista e sensibilità personale. Ecco che alla incomunicabilità con l’Altro-Cosa, il regista sovietico innesta un tema umanistico-naturalistico. Il film viene diviso in due parti. La prima (che dura quaranta minuti) è ambientata nella campagna, dove si trova la dacia del padre e dove Kris incontra anche un vecchio “solarista” per capire meglio cosa lo aspetta sulla stazione spaziale. Questa lungo segmento ha una continuazione con il viaggio e l’arrivo alla stazione e il primo incontro con gli ultimi superstiti e con il fantasma della moglie morta dieci anni prima, Hari. Qui è messo in scena il senso di abbandono e di solitudine, di incomunicabilità trasposta tra l’Altro-Cosa (Solaris) con l’alterità personale di Kris (il padre, la madre morta, la moglie suicida), dove la natura è una presenza metafisica che resiste al tempo. L’aspetto umanistico tarkovskijano è ancora più evidente dove la comunicazione con l’Altro-Cosa avviene tramite il subconscio dei personaggi: Solaris non fa che materializzare i ricordi e le fantasie più intime degli uomini e in questo caso della moglie morta di Kris, mentre lui sta dormendo. Il sonno della ragione (della razionalità) porta alla concretizzazione dell’irresolutezza dell’inconscio. Il rapporto con la moglie diventa una maieutica per immagini tra l’alterità interiore di Kris irrisolta e il dialogo incomprensibile con l’Altro-Cosa Solaris.
La lontananza dai sentimenti verso il padre da parte di Kris, il senso di perdita della madre, sono rappresentazioni simboliche della profondità dello Spazio-Tempo tra materiale e spirituale che viene messo in scena in Solaris, nella seconda parte dell’opera. La rappresentazione della stazione orbitante, caotica, spoglia, piena di rifiuti e di macchinari che funzionano poco e male; il silenzio, la luce proveniente dal pianeta, il liquido superficiale in continuo movimento (non acqua, ma umore amniotico da cui nascono e si materializzano i personaggi che il pianeta rievoca dal subconscio degli uomini); sono tutte metafore dell’annichilimento e della caducità dell’uomo di fronte al Mistero della Natura comunque rappresentata come alterità (sia terrestre sia solariana).

Kris dall’incomprensione prima alla paura poi, passa a cercare di dialogare e poi a innamorarsi della creatura fatta di neutrini (e non di atomi) che rappresenta la moglie. Più la creatura prende coscienza di sé, più lui si innamora e allo stesso tempo si dispera nei ricordi di un passato con cui non si è mai riconciliato e pieno di sensi di colpa.
Il cinema di Tarkovskij ha come tema portante questo bisogno di rappresentazione della natura, della solitudine dell’uomo (La casa isolata e la Zona in Stalker; la casa di campagna di Nostalghia; la taiga di Sacrificio) con inquadrature che sono long take messi in serie in modo addizionale e lineare. La fissità scopica sul mondo e sull’uomo, la pulsione verso l’Altro (sia esso interiore che esteriore) si delineano attraverso un’immagine-tempo di deleuziana definizione, in cui il movimento dell’anima e dei sentimenti dei personaggi sono rappresentati attraverso una messa in quadro che si dilata temporalmente nello spazio della visione.
Così, Solaris diventa un esempio di messa in scena del Tempo-Spazio all’interno dell’inquadratura e parla allo spettatore al proprio io interiore, ai sentimenti nascosti di solitudine (così come si è comunque soli nella visione collettiva della sala cinematografica) e di caducità della vita stessa.
La seconda parte di Solaris quindi si trasforma in un confronto tra scienza razionale e filosofia irrazionale, tra conoscenza e accettazione del Mistero, tra fideismo cieco e ricerca di una spiegazione. L’essere che materializza la forma della moglie di Kris, Hari, nel momento che prende coscienza di sé, si rende conto anche del dolore provocato a Kris e in una coazione a ripetere, si suicida con dell’ossigeno liquido. Ma essa vive perché vive la memoria nell’inconscio dell’uomo e si assiste alla sua contorsione corporea ed emotiva, della rinascita davanti a Kris, o meglio del ritorno da una diversa alterità, quella del Non-Essere.

Del resto, per far finire questo monologo da parte di Solaris (il tentativo di comunicare con la materializzazione dell’inconscio umano), i due scienziati trovano una doppia soluzione: da una parte inviare l’encefalogramma di Kris (che ha il contatto più avanzato e profondo con l’Altro-Cosa) e allo stesso tempo creare una macchina che annichilisce i neutrini, così da eliminare per sempre le forme materializzate. L’esperimento scientifico sembra riuscire: gli “ospiti” scompaiono (e la prima a sottoporsi al trattamento è il simulacro di Hari); Solaris recepisce l’encefalogramma di Kris provocando nuovi e numerosi sommovimenti sulla propria superficie.

Per Kris forse è ora di ritornare sulla Terra e infatti nell’ultima sequenza abbiamo lui nella dacia paterna in mezzo alla natura terrestre e inginocchiato chiede perdono al padre, per lenire i sensi di colpa. Ma, con un lento movimento all’indietro della macchina da presa, ci accorgiamo che si tratta di un’isola sorta sulla superficie amniotica di Solaris: l’irrazionale quindi ha il sopravvento; l’inconscio prende forma nella sua totalità; il Mistero dell’Altro-Cosa rimane intatto.
Vincitore del Gran Premio della Giuria al 25° Festival di Cannes nel 1972, Solaris rimane un grande esempio di cinema di fantascienza e uno dei tasselli fondamentali per la comprensione della breve, ma intensa, filmografia di Andrej Tarkovskij e del suo cinema poetico e umanistico, fatto di sequenze e di immagini di ampio respiro, che nel trentennale della scomparsa è ancora attuale e necessario.
Antonio Pettierre
“Rassegna Andrej Tarkovskij”, Fondazione Cineteca Italiana, Spazio Oberdan, Sala Alda Merini a Milano fino al 4 ottobre 2016 http://oberdan.cinetecamilano.it/eventi/andrej-tarkovskij/